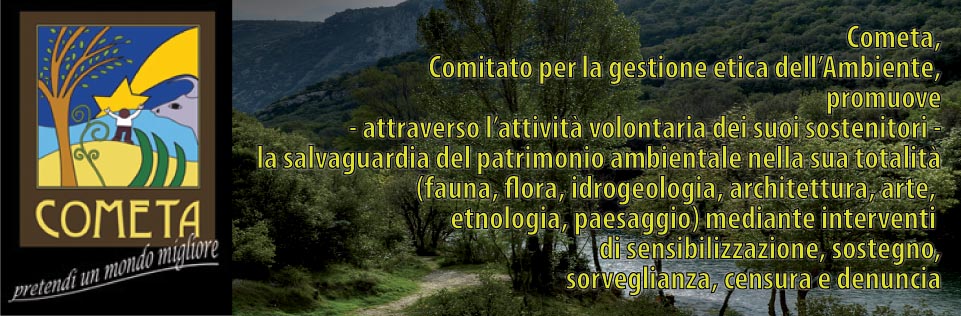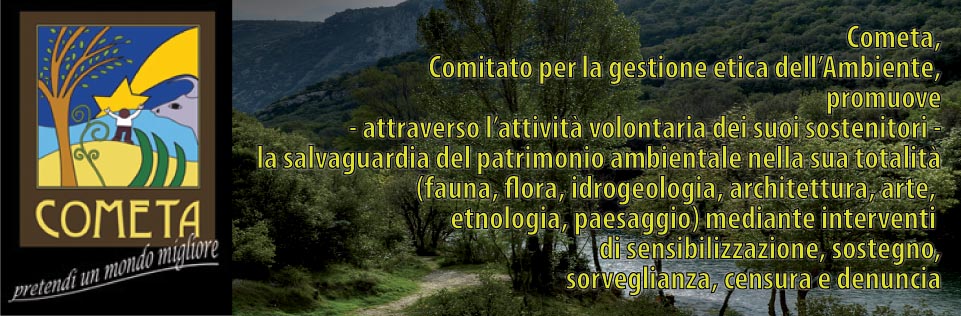abbiamo già visto in precedenti calendari che la Natura, pur nella estrema varietà delle forme delle sue creazioni, conosce e predilige le strutture geometriche. Dal piccolo al grande, dalle spirali del DNA alla forma delle galassie, dalla struttura dei cristalli alle celle degli alveari, le leggi naturali impongono configurazioni che, oltre a rispondere a requisiti di efficienza, appaiono particolarmente belle ed eleganti. Non c'è da stupirsi: l'essere umano è parte della Natura, con cui mantiene un'intima risonanza; quindi anche la sua valutazione estetica risente di questo legame. Inoltre ogni forma di vita combatte contro il caos, e nulla meglio di una struttura geometrica rappresenta la vittoria contro l'entropia, contro il disordine verso il quale il cosmo fatalmente di dirige.
E' dunque del tutto ovvio che molti artisti abbiano tentato di riprodurre nelle loro opere i tesori geometrici generati spontaneamente da madre Natura.
Nel 1936 Maurits Cornelis Escher, insieme alla moglie Jetta, lasciò l'Italia per un viaggio in Spagna. Benché a quell'epoca non avesse ancora raggiunto la celebrità, Escher era già stimato come valente incisore*, tant'è che pagò il viaggio cedendo alla compagnia di navigazione una serie di matrici, un espediente di cui forse non aveva bisogno, essendo di famiglia benestante (la moglie, poi, era figlia di un banchiere svizzero). Tant'è che negli anni tra il 1922 e il '36 aveva potuto girovagare per l'Italia, insieme a un gruppo di amici, fermandosi qua e là (soprattutto della costiera amalfitana, dove conobbe la moglie, in Abruzzo in Calabria, in Sicilia) a ritrarre villaggi e panorami. Fu proprio il viaggio in Spagna, e soprattutto la sua visita del palazzo dell'Alhambra, che diede un impulso eccezionale alla sua maturazione artistica, perché dagli ornamenti geometrici moreschi Escher trasse molte idee che ispirarono le sue opere successive.
E' dalle decorazioni dell'Alhambra che Escher trasse l'idea di inserire nelle sue opere le tassellature del piano, ovvero la suddivisione continua del piano in figure che si ripetono (e che danno l'idea di moltiplicarsi all'infinito, estendendosi anche fuori dalla superficie visibile). Anziché utilizzare un'immagine astratta come disegno di base per il singolo tassello, Escher adottò un animale e talvolta più animali di tipo diverso (come in Uccelli e pesci, 1938) o progressive mutazioni (come in Cielo e acqua, 1938, dove i pesci si trasformano gradualmente in uccelli) fino a Mosaico II, 1957, dove la tassellatura include animali (pesci, uccelli, elefanti, serpenti, ...) insieme a figure umane, diavoletti e oggetti.
I massimi risultati dello sviluppo dell'idea artistica della tassellatura del piano generano delle metamorfosi: in Giorno e notte, 1938, il piano piastrellato con uccelli bianchi e neri che volano in direzioni opposte congiunge due immagini speculari, l'una diurna e l'altra notturna, di un paesino posto sulla riva di un fiume (quindi la metamorfosi è di carattere meteorologico); in Rettili, 1943, piccoli coccodrilli abbozzati su un foglio di carta prendono vita, forma e colore, vanno in giro per l'ambiente grafico e tornano alla loro esistenza grigia e massificata (qui la metamorfosi è complessa: passaggio dalla non-vita alla vita e simultaneamente dal gruppo indifferenziato all'individuo).
L'arte di Escher è stata accusata a lungo di essere eccessivamente cerebrale, il che costò all'incisore un duraturo periodo di noncuranza da parte della critica. Ma nel 1965 un affermato intellettuale, Albert Flocon, incisore, pittore, letterato, pubblicò sulla rivista Jardin des Arts un articolo elogiativo che definiva le opere di Escher capaci di rappresentare «una struttura plausibile che contraddice la nostra esperienza quotidiana e la mette in discussione». L'articolo attirò l'attenzione dei critici di tutto il mondo innescando quella che fu chiamata «Eschermania», che sfociò nel grande successo della mostra dell'Aja del 1968, che consacrò l'artista anche agli occhi del grande pubblico.
Non c'è comunque da credere che Escher basasse le sue costruzioni su un qualche tipo di teoria formale o di accademia. Come Einstein, Escher non era stato un buon studente; ogni tanto la storia umana ci consegna personaggi che non hanno bisogno di istruzione: sono compenetrati dalla spontaneità del genio, le strutture si aggirano nelle loro teste senza necessità di formule, e quando emergono sono strabilianti. Come leggiamo nella biografia redatta dal suo amico Bruno Ernst, Escher dice di sé: «ero un ragazzo gentile e un po' stupido a scuola. Immaginatevi adesso che i matematici illustrano i loro libri con i miei quadri! E io che vado in giro con gente colta quasi fossi loro fratello o collega. Non riescono neppure a immaginarsi che io non ne capisco nulla». In effetti l'umiltà si accompagna spesso al genio.
nell'immagine: Geco, 1963
______________________
* Escher ci ha lasciato soprattutto xilografie (incisioni su legno) e litografie (incisioni su lastra di metallo) in massima parte in bianco e nero. Durante la sua vita ha prodotto un complesso di 448 lastre, ognuna delle quali ha avuto molte tirature, e più di 2000 tra disegni e schizzi, sopratutto preparatori delle matrici per l'incisione
** è ben nota la ragione per cui l'arte islamica ha privilegiato la geometria astratta. Benché il Corano non imponga proibizioni alla rappresentazione di figure umane e di animali, fin dall'epoca del profeta Maometto i religiosi paventavano il rischio di confondere l'immagine con la sostanza e quindi di cadere nella superstizione o nell'idolatria: «O mio Signore, rendi sicura questa contrada e preserva me e i miei figli dall'adorazione degli idoli.» (Sura XIV). Per questo motivo gli elementi decorativi dell'architettura islamica, chiamati non a caso arabeschi, sono di carattere astratto e rigorosamente geometrico, e il palazzo dell'Alhambra, a Granada, ne costituisce probabilmente la massima rappresentazione.
Il rischio di adorare rappresentazioni della maestà divina in quanto tali, dimenticando che si tratta per l'appunto solo di rappresentazioni, è presente in tutte e tre le religioni abramitiche e trova fondamento nella Bibbia: «non avrai altri dèi di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai» (Esodo, 20, 1-6).
Anche nel Cristianesimo l'iconoclastia, ovvero la distruzione di immagini, sculture e altre rappresentazioni della divinità e della natura è stata una corrente di pensiero (e di azione) duratura, che ha portato alla distruzione di un ingentissimo patrimonio di opere d'arte. Fu abolita definitivamente solo nell'843 da papa Gregorio IV ma trovò un seguito spettacolare nella Riforma protestante, che nel '500 e nei secoli successivi cancellò dalla faccia della terra perfino chiese e cattedrali. Un esempio contemporaneo di iconoclastia risale al 2001, quando i Talebani distrussero due gigantesche statue del Buddha nella città di Bamiyan (ricostruite nel 2003 e inserite nel Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO)